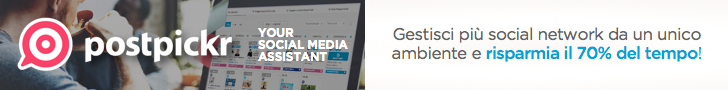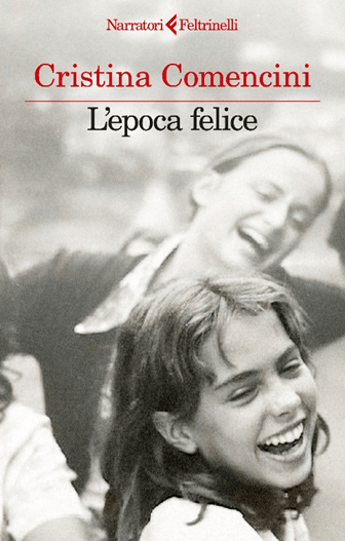La felicità come forma di resistenza, di intimità e di presenza viva. Qualcosa da cercare, da riscoprire, da custodire. Il nuovo romanzo di Cristina Comencini, “L’epoca felice” (Feltrinelli), in libreria dal 14 ottobre, è un invito a tornare dove tutto è cominciato: all’adolescenza, alla libertà e al desiderio di vivere.
Negli anni Settanta, in alcune famiglie borghesi, le ‘esuberanze’ adolescenziali venivano affrontate con lunghi ricoveri in cliniche del sonno: luoghi di sedazione, di rimozione, di normalizzazione. I genitori di Rosa – spaventati da brutti voti e da un’energia che non sapevano contenere – la affidarono proprio a uno di questi centri ‘di cura’. Ora Rosa è una donna adulta, medico con anni di missioni umanitarie alle spalle. Tornando in Italia, viene accolta dalle sorelle. Una vecchia fotografia scattata in montagna riapre squarci di tempo dimenticato: in quella quindicenne spensierata, che tanto allarmava gli adulti, Rosa riconosce oggi la parte più viva e autentica di sé. Ma dov’è finita quella ragazza? E chi è il giovane che scattò quella foto, perché quel gesto le appare così intimo, urgente, necessario da conservare? Per ricomporre i frammenti della sua memoria, Rosa ha bisogno delle sue sorelle: Margherita, la maggiore, che di quella gita conserva ricordi precisi, e Viola, la più giovane, disposta a rompere con lei il silenzio della famiglia.
Con la sensibilità che la contraddistingue, la scrittrice e regista Cristina Comencini illumina l’adolescenza come un prisma capace di catturare la felicità nella sua forma più intensa, turbolenta e trasformativa. E ci ricorda una verità dimenticata: essere felici è ancora possibile. Basta non lasciarsi sottrarre quella possibilità. In un mondo che spesso ci scoraggia, la felicità resta una meta fragile ma reale. Non una certezza, forse, ma una tensione profonda dell’anima.
Il romanzo “L’epoca felice” – con grazia, intelligenza e precisione emotiva – racconta esattamente questo: la felicità come forma di resistenza, di intimità e di presenza viva. Qualcosa da cercare, da riscoprire, da custodire. Si comincia dai bambini, per i quali la felicità è condizione spontanea, non ancora delegata alla performance. Nei loro occhi non c’è merito da dimostrare, solo presenza, curiosità, vita. È una lezione antica che troppo spesso dimentichiamo crescendo.
Nell’adolescenza quella tensione cambia volto ma non intensità: si esprime in un desiderio assoluto, nel bisogno limpido e ostinato di dare alla vita un senso autentico. Eppure, spesso è proprio il mondo adulto – normativo, impaurito, cieco – a reprimere quella scintilla. Come scriveva Natalia Ginzburg, agli adolescenti non servono prediche: basta la nostra presenza, silenziosa e discreta. È ciò che vive Rosa da ragazza: le sue giornate vibrano di una libertà istintiva, che porta con sé l’urgenza e la meraviglia del fare.
Crescendo, però, tutto cambia. La felicità si trasforma da esperienza a progetto: bisogna costruirla, guadagnarsela, raggiungerla. Diventa una prestazione. E in questo passaggio rischia di perdersi per sempre. Eppure, forse, la felicità è un’altra cosa: una tessitura silenziosa, una presenza, non un obiettivo da raggiungere, ma una possibilità da riconoscere. La nostra cultura ignora tutto questo. Nei media la felicità non fa audience, non fa notizia. Il suo linguaggio è troppo mite, troppo profondo per un mondo che vuole spettacolo. Perfino nella letteratura sembrano prevalere visioni disilluse: il pensiero leopardiano, dove il piacere è sempre figlio dell’affanno, ha creato un clima di sospetto verso la gioia. A ostacolare la felicità contribuiscono inoltre i messaggi ricevuti fin da piccoli: frasi chiuse e ammonimenti travestiti da saggezza. “La vita è dura”, “Accontentati”, “L’ozio è il padre dei vizi”, “L’erba voglio non esiste”. Formule che non educano alla fiducia, ma alla rinuncia; non invitano a esplorare, ma a obbedire, a credere che la felicità non sia per noi, o che sia un privilegio da meritare. E anche i giovani di oggi respirano questa logica, sebbene in forme nuove. Le cosiddette “vacanze dei diciottenni”, che dovrebbero essere spazio di leggerezza ed esplorazione, sembrano segnate da controllo, gelosie, ansie. Al massimo, un picnic. La libertà si è fatta invisibile. La leggerezza, un rischio da evitare. A questo punto, la domanda diventa inevitabile: se la Costituzione americana riconosce come diritto “la ricerca della felicità”, la nostra società — più della legge, la nostra mentalità collettiva — ci autorizza davvero a cercarla? O ci insegna a ridimensionarla, quasi fosse un sogno per ingenui? Il nuovo romanzo di Cristina Comencini è una risposta delicata e potente a questa domanda. Un invito a tornare dove tutto è cominciato: all’adolescenza, alla libertà e al desiderio di vivere. (di Paolo Martini)