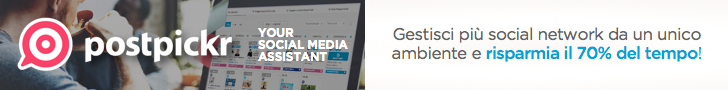Sono cellule sfuggenti, lupi solitari che si staccano dal gruppo, cambiano faccia all'occorrenza e permettono al cancro di evadere le terapie. Un team di scienziati italiani di base negli Usa ha usato tecnologie all'avanguardia per localizzarle e studiarle. I risultati della loro ricerca, pubblicati di recente sulla rivista 'Cancer Cell', aggiungono tasselli importanti per decifrare i segreti della plasticità tumorale. A firmare il lavoro sono Anna Lasorella, co-direttrice del Sylvester Brain Tumor Institute (Sbti) e direttrice della Sylvester's Precision Medicine Initiative, e Antonio Iavarone, direttore Sbti e vicedirettore del Sylvester, coppia d'oro della ricerca oncologica che al Sylvester Cancer Center dell'University of Miami ha focalizzato i suoi studi su una neoplasia altamente letale, il glioblastoma, tempo medio di sopravvivenza di poco superiore a 1 anno dalla diagnosi. Questo tumore ricompare quasi sempre dopo il trattamento iniziale e le forme ricorrenti sono sempre resistenti alla terapia. Il punto di partenza è dunque questo. Il passo avanti, invece, è che gli scienziati – utilizzando una piattaforma che si chiama CosMx nel centro che fa parte della Miller School of Medicine dell'ateneo di Miami – sono riusciti a vedere e classificare le singole cellule nelle loro posizioni originali nel tumore. E hanno scoperto che le cellule del glioblastoma che si 'raggruppano' insieme ad altre cellule dello stesso tipo sono meno letali. Mentre le cellule 'disperse' nel tumore, quelle che escono dal gruppo, sono vere 'trasformiste': sono più plastiche, termine biologico che indica cellule malleabili e in grado di assumere forme o stati diversi. La plasticità è un attributo indesiderato per il cancro, poiché è correlata alla resistenza al trattamento e a esiti peggiori per il paziente. Ma la causa di questa plasticità del cancro è finora un mistero. Lasorella e Iavarone accendono i riflettori su una possibile chiave di lettura: le relazioni spaziali fra le cellule. La geografia conta, in altre parole. "Da molti anni – spiega Iavarone all'Adnkronos Salute – si sa che il motivo fondamentale dell'elevata aggressività dei tumori più maligni, come il glioblastoma ma non solo, è che ci sono delle cellule che riescono ad adattarsi e a sopravvivere a diverse condizioni ambientali molto difficili come la mancanza di ossigeno, la presenza di farmaci tossici quali la chemioterapia. Ci riescono attraverso la plasticità, la capacità di modificarsi continuamente. Ci siamo chiesti perché alcune cellule non cambiano e possono essere bersagliate e altre invece si trasformano e resistono. Per capirlo abbiamo aggiunto analisi computazionali completamente nuove a tecnologie potenti che consentono di studiare le caratteristiche molecolari, le attività di tutti i geni di ogni singola cellula, mantenendo intatta la struttura geografica del tumore e studiando le cellule direttamente in questo spazio. Si chiama trascrittomica spaziale". Questa strategia, continua Iavarone, "ci ha consentito di studiare milioni di cellule nel loro spazio naturale. E abbiamo potuto scoprire come funziona il meccanismo della plasticità: le cellule che aderiscono fra di loro e rimangono organizzate in cluster rimangono molto simili e sono quelle che noi riusciamo a distruggere con la chemioterapia. Quelle che si staccano", i lupi solitari, "sono cellule che si mascherano continuamente, hanno 10 fenotipi diversi e si adattano enormemente alle condizioni ambientali che trovano. Possono passare da cellule neuronali a cellule che proliferano, da cellule quiescenti a cellule che invadono, a seconda di quello che serve per sopravvivere. E sono le più aggressive, quelle che non si riesce a distruggere. Noi abbiamo per la prima volta scoperto questo meccanismo: per poter diventare plastiche, le cellule devono perdere l'adesione tra di loro in questi cluster e diventare disperse". Il trattamento iniziale dei tumori cerebrali con chemio o radioterapia, è dunque l'ipotesi, potrebbe effettivamente rompere i cluster relativamente meno dannosi di cellule tumorali e stimolarne la dispersione – affermano i ricercatori – il che significa che le cellule rimaste dopo il trattamento diventano più plastiche e quindi più aggressive per il paziente. Quello che è chiaro al momento è che le cellule disperse e quelle raggruppate si comportano in modo molto diverso nel tumore. In studi precedenti, Lasorella, Iavarone e colleghi avevano identificato 4 diversi gruppi di cellule di glioblastoma, in base ai geni specifici attivati in ciascun tipo di cellula. Nello studio attuale hanno esaminato come questi 4 gruppi sono organizzati nei tumori, rilevando che in certe aree del tumore i tipi cellulari sono mescolati insieme, definendo così la conformazione dispersa. Infine hanno esaminato le differenze fra le cellule in cluster e le cellule disperse, scoprendo che quelle raggruppate esprimono proteine sulla loro superficie che le aiutano a rimanere unite, mentre le disperse perdono queste proteine. Gli autori hanno anche osservato che gli stessi principi si applicano a campioni isolati da pazienti affette da cancro al seno: le cellule tumorali disperse sono più plastiche delle 'colleghe' organizzate in cluster. E la plasticità delle cellule tumorali favorisce la metastasi dei tumori solidi. Sebbene il glioblastoma non metastatizzi allo stesso modo degli altri tumori solidi, comprendere meglio la plasticità potrebbe aiutare a chiarire perché e quando molti tumori fanno metastasi. "Riteniamo che questo principio sia di importanza generale", dice Iavarone. Un altro quesito al quale si sta cercando una risposta è se le cellule disperse esprimano determinate proteine o molecole che interrompono l'adesione e, in tal caso, se tali proteine possano essere eventuali bersagli farmacologici per promuovere l'aggregazione. L'idea, in ogni caso, spiega lo scienziato, è di "sfruttare questo meccanismo dell'adesione, forzarlo nelle cellule che non ce l'hanno", per poi colpire con un'arma mirata al gruppo. "Se riusciremo a comprendere meglio questo meccanismo – ragiona Lasorella – speriamo di poter mantenere le cellule raggruppate meno plastiche in quello stato, o addirittura invertire la dispersione delle cellule più plastiche". Sarebbe, conclude Iavarone, "un passo avanti per essere più efficaci con la terapia". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Home Rubriche Ambiente e salute Caccia alle cellule trasformiste del cancro, la sfida di due scienziati italiani...